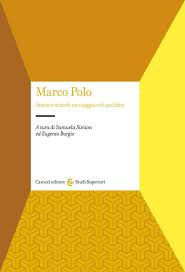Rereading Travellers to the East in Post-Unification Italy, Firenze University Press, 2022
- Nov 16, 2023
- 8 min read
Updated: May 15, 2024
Rereading Travellers to the East:
Shaping Identities and Building the Nation in Post-unification Italy.
A cura di Beatrice Falcucci, Emanuele Giusti, Davide Trentacoste
Firenze: Firenze University Press, 2022, Pp. 229.

C’è assai poco spazio per l’Italia in un libro di Edward Said – Orientalism – che ha fatto storia e rivoluzionato il modo di guardare criticamente alla rappresentazione dell’“Oriente” nella cultura europea. Tuttavia anche l’Italia, non diversamente da altri paesi, ha alimentato una propria forma di “orientalismo” in cui incardinare fantasie, raffigurazioni e deformazioni letterarie con cui plasmare un proprio immaginario dell’Asia. Per buona parte del Novecento questo immaginario e le sue propaggini accademiche sono maturate entro gli spazi ben definiti della sinologia, della tibetologia, dell’arabistica, dell’indologia e della linguistica comparata. Con il nuovo millennio, sotto la spinta di un transnational turn, il dibattito si è aperto agli storici della letteratura e a una rilettura della storia dell’orientalismo italiano condotta contro la lente di categorie e metodologie critiche desunte, come c’era da aspettarsi, dal filone degli studi postcoloniali di matrice anglosassone. Ci si è incominciato a domandare allora quale fosse la fisionomia degli “orienti”, reali o immaginari, prodotti dalla letteratura e cultura italiane da Matteo Ricci a Berchet, dalla Turandot di Puccini a Chung Kuo di Antonioni, dai reportage di Calamandrei o Terzani alle scene distopiche di Tommaso Pincio in Cinacittà, e quale funzione simili reportage di un altrove reale o immaginario abbiano avuto nel dibattito culturale della penisola.
La raccolta di saggi curata da Beatrice Falcucci, Emanuele Giusti e Davide Trentacoste in Rereading Travellers to the East si inserisce nella scia di questo crescente interesse interdisciplinare rivolto alle origini e contraddizioni d’un ”orientalismo” specificamente italiano. Abbracciando un periodo fondamentale, che va dalla formazione dello stato unitario all’avvento del Fascismo, il libro intreccia un ampio fascio di “contatti” e interazioni che hanno legato l’Italia postunitaria all’Asia, al Medio Oriente e all’Africa: dal coinvolgimento di Giovanni Gentile nella fondazione l’Istituto Italiano per il Medio e Estremo Oriente di Giuseppe Tucci all’appropriazione ideologica di Marco Polo promossa dal Fascismo, dagli exploits dell’architettura coloniale italiana nel Dodecaneso e nel Mediterraneo orientale ad una prima cartografia (rimasta sino a questo momento ignota) della storia della letteratura di viaggio italiana in Persia.
Perno dell’intero mosaico di analisi è l’obiettivo di decostruire le varie “ri-letture” con cui la cultura postunitaria ha tentato di resuscitare, appropriandosene, l’alone “mitico” d’una passata tradizione letteraria di viaggiatori ed esploratori d’eccezione. Grazie a questa (surrettizia) storia illustre di precoci contatti che vanno idealmente da Polo a Matteo Ricci, passando attraverso l’epopea commerciale di Genova e Venezia, l’Italia avrebbe così “scoperto” l’Asia ben prima degli altri paesi Europei. È precisamente questo “mito” storiografico e letterario dei “viaggiatori italiani in Oriente”, fabbricato ad arte in un contesto tardo Ottocentesco, che i curatori e gli autroi di Rereading Travellers to the East pongono sotto una lente d’ingrandimento. Perché come spesso accade nella storia della penisola, la glorificazione retroattiva di un presunto “primato” culturale rivela facilmente i tratti d’una “compensazione” con cui mascherare una ben più cocente marginalità dell’Italia sul piano economico e politico. Il “mito” dei viaggiatori italiani in Oriente è stato in altri termini un ornamento erudito con cui decorare aspirazioni ben meno idilliche dell’Italia prefascista nella brutale arena delle ambizioni coloniali di fin de siècle.
Le prime indagini sistematiche sulla storia dell’orientalismo nella letteratura italiana di Barbara Spackman (Accidental Orientalist: Modern Italian Travelers in Ottoman Lands, Liverpool: Liverpool University Press, 2017) e Fabrizio de Donno (Italian Orientalism: Nationhood, Cosmopolitanism and the Cultural Politics of Identity, Oxford: Peter Lang, 2019) hanno messo in evidenza il bisogno di interrogarsi sul rapporto fra questi miti orientalisti e la (ri)costruzione di una identità “italiana” che fu obiettivo portante della cultra postrisorgimentale. Ampliando questo filone di ricerca, -Reading Travellers to the East mette a nudo il meccanismo cruciale posto alla base dell’articolazione intellettuale dell’orientalismo italiano: un meccanismo di compensazione. L’Italia di fine Ottocento – e ancor più quella Fascista – “ha avvertito il bisogno di di compensare le perdite e una mancanza di rilievo nell’arena internazionale richiamandosi ad un passato glorioso di viaggiatori e inventori” noto a tutti (p. 13). Una tradizione “orientalista” letterariamente inventata ha così dovuto supplire ai magri risultati di una deludente, e spesso delusoria, politica estera.
Il contributo d’apertura del volume di Beatrice Falcucci, “Rievocare certe nobili opere dei nostri maggiori”: the Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO) and the ‘Myth’ of Italian Travellers to the East”, pone una prima pietra angolare nell’architettura del volume ricostruendo la storia, sin qui largamente dimenticata, dell’IsMEO, l’Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, fondato nel 1933 da Giuseppe Tucci con il sostegno di Giovanni Gentile. La storia dell’IsMEO mette bene a nudo tutte le tensioni ideologiche che animarono le fantasie orientali(stiche) del Fascismo. Se al cuore della politica di potenza fascista stava il desiderio di “ricostruire un (immaginario) impero italiano”, scrive Falcucci, gli studi orientalisti avevano l’obiettivo di confermare, costasse quel che costasse in termini di correttezza storica, “che gli italiani erano arrivati ‘prima’” in Asia, in una implicita competizione con gli studi ben più fiorenti maturati in ambito francese, britannico e tedesco. L’erudizione storiografica doveva servire da giustificazione a dubbie rivendicazioni coloniali (pp, 29-30). Il capitolo successivo di Fabrizio de Donno (“Rereading Italian Travellers to Africa: Precursors, Identities and Interracial Relations in Narratives of Italian Colonialism”) sposta l’attenzione sulle “trasformazioni della coscienza colonial italiana” in riferimento all’Africa Orientale, il caso certamente più drammatico nella storia dell’imperialismo Fascista. Lo scavo critico di De Donno mette così a confronto l’appropriazione fascista degli scritti di Pellegrino Matteucci (1850-1881), uno dei più importanti esploratori italiani in Etiopia, con le ben diverse riletture postcoloniali di due testi chiave della letteratura coloniale italiana – XX Battagione Eritreo di Indro Montanelli (1936) e Settimana nera di Enrico Emanuelli (1961) –compiute in questo caso da Angelo Del Boca e Igiaba Scego, che hanno commentato e ricontestualizzato le opere di Montanelli e Emanuelli nella loro prospettiva storica. Un simile dialogo intertestuale è volto a districare la complessa parabola seguita dalla memoria culturale del colonialismo italiano e dalle sue, spesso contraddittorie, riconfigurazioni passate attraverso la “celebrazione” del colonialismo di epoca fascista, l’”amnesia” del dopoguerra e una tardiva anamnesi dei crimini coloniali italiani emersa solo a partire dagli anni Ottanta.
I saggi di Alessandro Tripepi (“Unsheathing the Katana. The Long Fortune of the First Two Japanese Embassies in Italy: Rediscovery and Rereading between Continuity and and Discontinuity”, pp. 83-103) e Aglaia de Angeli (“Ludovico Nocentini: A Rereader of Modern Italian Travellers to China”, pp. 103-124) si confrontano con le riletture/riappropriazioni di altri episodi rilevanti nella storia delle relazioni fra Italia e Asia. Tripepi si concentra sul dibattito storiografico e sulla riscoperta delle prime due missioni diplomatiche in Europa del Giappone moderno – l’ambasciata Tenshō (1582-1590) e la ben meno fortunata ambasciata Keicho (1613-1620) – esaminando in che modo la storiografia e la stampa italiano hanno reinterpretato questi primi contatti fra Giappone, Europa e Italia all’indomani del ripristino di formali contatti diplomatici con l’Europa promossa durante la restaurazione Meiji da Iwakura Tonomi, padre fondatore della politica estera del Giappone contemporaneo. Il saggio di de Angeli, invece, fa uso di una serie di categorie teoriche derivate da Barthes, Derrida e le Lecture on Literature di Nobokov per far luce sulla riscoperta ottocentesca del più celebre viaggiatore italiano in Cina dopo Polo: Matteo Ricci. Dopo un prolungato oblio nel corso del 17esimo secolo, legato alle vicissitudini che accompagnarono la soppressione della Compagnia di Gesù, de Angelis individua in un libro dello studioso Ludovico Nocentini (Il primo sinologo: P. Matteo Ricci, pubblicato nel 1882), un punto di svolta in una riappropriazione “secolare” dell’opera di Ricci intesa riplasmare la stessa figura di Ricci come fondatore “italiano” della “sinologia in quanto disciplina” (p. 117). Le relazioni fra Cina e Italia sono anche al centro del capitolo di Laura de Giorgio, “An Italian Hero for China: Reading Marco Polo in the Fascist Era”, dove l’autrice indaga la (mis)appropriazione ideologica della figura di Marco Polo perseguita dalla cultura di epoca fascista. Funzionale all’immagine di un “colonialismo civilizzatore” avanzata dal Fascismo nella sua politica asiatica, Polo venne evocato dalla propaganda di regime nei termini di un ritratto idealizzato del “buon” colonizzatore, precursore della “capacità storica dell’Italia di intrecciare dialogo e cooperazione con l’Oriente”: tuttavia, come De Giorgio acutamente sottolinea, simile miticizzazione di Polo come “modello eroico” di un proto-colonialismo medievale fu destinata a gettare un’ombra persistente sul dibattito critico cinese dedicato all’opera poliana (pp. 174-175).
I contributi di Luca Orlandi, Davide Trentacoste e Emanuele Giusti esplorano invece territori sino a questo momento largamente inesplorati nella storia delle relazioni culturali fra Italia e Asia. Orlandi offre una indagine relativa alle politiche di gestione del patrimonio artistico e cultural heritage poste in essere dallle autorità fasciste nelle isole del Dodecaneso (“Searching for ‘Italianità’ in the Dodecanese Islands (1912–1943). Some Considerations on Art, Architecture and Archaeology through the Works of Hermes Balducci”). La micro-biografia intellettuale che Orlandi dedica alla figura di Hermes Balducci, figura poliedrica di architetto, ingegnere e designare che diresse l’Istituto Storico Archeologico FERT istituito a Rodi dalle autorità coloniali italiane offre spunti cruciale per valutare criticamente l’impatto delle ideologie fasciste di romanità e italianità nella ricerca archeologica nel Mediterraneo orientale. Il capitolo di Trentacoste (Medici Ambitions and Fascist Policies. (Re)reading the Relations between Italy and the Levant in the 1930s through the Historiography on Fakhr al-Din II, pp. 141-160) riporta alla luce la storia largamente dimenticata di Fakhr al-Dīn Maʿn (1572-1635), governatore del Libano ottomano, e il suo coinvolgimento nelle “ambizioni orientali” coltivate dal Granducato di Toscana all’indomani della Battaglia di Lepanto. Trentacoste esamina la tardiva “riscoperta” di Fakhr al-Din tempestosa carriera diplomatica sponosrizzata dalla Reale Accademia d’Italia nel corso degli anni Trenta e acutamente riallaccia questo improvviso interessa accademico verso Fakhr al-Din a ben più pragmatici (e implicitamente anti-britannici) interessi della politica estera fascista nel Levante. Il contributo di di Emanuele Giusti (“The Idea of Italian Travellers to Iran. Scholarly Research and Cultural Diplomacy in Post-war Italy”, pp. 181-210) presenta un’ambiziosa sintesi della storia delle letteratura di viaggio italiana in Persia che dagli scritti di Ricoldo di Montecroce (1243-1320) arriva alle moderne campagne archeologiche lanciate dall’IsMEO di Tucci in Iran, in parallelo tutt’altro che coincidenziale con una rete di interessi economici perseguiti nella regione perseguiti dall’ENI di Enrico Mattei. Scandagliando un impressionate repertorio di fonti, Giusti riesce a mettere in luce come simile tradizione letteraria venne retrospettivamente storicizzata per “incarnare l’idea di un continuo scambio culturale fra “civiltà”, in modo da forgiare un impromptu ponte culturale fra tradizioni nazionali profondamente distanti (p. 183).
Il contributo finale del volume di Giovanni Tarantino (“Notes on Rereading and Re-enacting China”, p. 211-220) conclude il volume con una provocante e acuta riflessione concernete la nachleben del documentario Chung Kuo, Cina, filmato da Michelangelo Antonioni nel mezzo della Rivoluzione Culturale. Sponsorizzato a suo tempo dalla leadership politica maoista, Chung Kuo nondimeno si scontrò con un furioso backlash e finì per essere censurato in Cina: Tarantino prende questo inatteso contraccolpo proveniente dagli spettatori cinesi per mostrare come il documentario di Antonioni possa essere “letto e riletto in molti modi”, visto attraverso “diversi sguardi”: dalla prospettiva di un ingenuo “pubblico europeo”, “curioso nei confronti di un socialismo non sovietico”, o attraverso lo sguardo radicalmente diverso del pubblico cinese, e finalmente attraverso lo stesso sguardo dei soggetti ripresi da Antonioni, che fissano la camera del regista “nella malinconia austerità della propria povertà” (p. 216). È proprio attraverso questa molteplicità di sguardi, di infinite appropriazioni e riappropriazioni, che gli autori di Re-Reading Travellers to the East hanno brillantemente ricostruito le infinite appropriazioni e riappropriazioni attraverso cui l’Italia ha plasmato e riplasmato la propria, autoctona, immagine dell’“Oriente”.
Tommaso Pepe, Guangzhou Maritime University.
Una versione in lingua inglese di questa recensione è apparsa su Annali d'Italianistica, vol. 41, 2023.