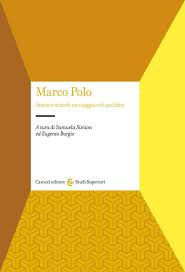Un lungo cammino. La politica diplomatica tra Santa Sede e Cina, Edizioni Nuova Cultura, 2023
- Nov 30, 2023
- 5 min read
Updated: May 15, 2024
Xie Sijie Un lungo cammino. Prodromi ed esiti della politica diplomatica tra Santa Sede e Cina Roma: Edizioni Nuova Cultura, 2023, 439 Pp.

Nel vasto intreccio di interazioni culturali che hanno legato Europa e Asia la storia delle relazioni fra la Chiesa cattolica e la Cina occupa un posto del tutto particolare. Il papato medievale fu la prima istituzione europea a coltivare rapporti diretti con l’Asia, attraverso le sparute ma tenaci delegazioni di frati francescani e dominicani che percorsero le vie dall’impero mongolo a partire dal XIII secolo. Le missioni gesuite insediatesi alla corte Ming furono protagoniste d’uno dei più complessi e problematici scambi culturali nelle relazioni fra Oriente e Occidente. La disputa dei riti, le persecuzioni anticristiane che segnarono la rivolta dei Boxer o la delicata questione dei (non) rapporti diplomatici fra il Vaticano e il governo della repubblica popolare cinese non hanno fatto altro che aggiungere altro materiale ad una storia eccezionalmente densa e intricata.
Sula base di attento lavoro di scavo documentario in archivi italiani e cinesi, Xie Sijie ha ricostruito un tassello cruciale di questo “lungo cammino” indagando la delicata rete di contatti con cui, tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, la Santa Sede, l’impero Qing e poi il governo nazionalista della repubblica cinese negoziarono l’apertura di formali relazioni diplomatiche. Il risultato di questo lavoro, Un lungo cammino. Prodromi ed esiti della politica diplomatica tra Santa Sede e Cina, illumina così un capitolo particolarmente importante nella storia delle relazioni fra la Chiesa e la Cina contestualizzandolo sullo sfondo di eventi tanto importanti quanto drammatici: dagli ultimi anni di declino della dinastia Qing alla rivoluzione Xinhai, dalla forzata renovatio della diplomazia pontificia seguito alla “questione romana” al Concilio Vaticano II, dall’instaurazione della Repubblica Popolare nel 1949 agli ultimi contatti diplomatici maturati durante il pontificato di Jorge Bergoglio.
Il primo capitolo del volume si apre con un’analisi dei contatti diplomatici diretti fra la Santa Sede e l’impero Qing sul finire dell’Ottocento. Questione cruciale indagata da Xie è la fine del cosiddetto “protettorato” francese sulle missioni cattoliche in Cina, accompagnata dagli sforzi congiunti della diplomazia vaticana e dell’impero cinese volti ad instaurare contatti ufficiali diretti liberi dall’“intermediazione” di governi europei. Figura chiave di questi negoziati fu Li Hongzhang, influentissimo viceré di Zhili e plenipotenziario de facto della politica estera cinese nell’ultimo quarto del XIX secolo. A seguito dei trattati di Huangpu (1858) e della convenzione sinofrancese di Pechino (1860) la Francia aveva infatti rivendicato un ruolo di tutela e supervisione verso le istituzioni ecclesiastiche e comunità cristiane presenti sul suolo cinese, sovrapponendosi e talvolta esautorando la stessa autorità pontificia. Furono tuttavia proprio una serie di contatti epistolari fra Li Hongzheng e Papa Leone XIII nel corso degli anni Ottanta dell’Ottocento, brillantemente esaminati da Xie, a porre le premesse per una “soluzione di compromesso” che, pur mantenendo formalmente in esistenza il protettorato francese, ne ridimensionò portata e influenza attraverso la nomina del primo nunzio apostolico in Cina, il cardinale Antonio Agliardi.
Agliardi tuttavia non ebbe mai modo di recarsi personalmente a Pechino: gli eventi caotici che accompagnarono la rivolta dei Boxer (1899-1901), la rottura delle relazioni diplomatiche fra la Francia e la Santa Sede (1904) e soprattutto la rivoluzione Xinhai rimisero infatti tutto in discussione. Toccò allora al pontificato di Benedetto XV (1914-1922), a cui viene dedicato il secondo capitolo del libro, tentare di ripristinare il progetto di un riconoscimento diplomatico fra il Vaticano e il nuovo governo repubblicano: sforzi che furono però a loro volta vanificati dai profondi sconvolgimenti causati dal primo conflitto mondiale. Nel terzo capitolo del libro l’attenzione viene concentrata sul pontificato eccezionalmente complesso di Pio XI. Universalmente noto per la firma dei Patti Lateranensi e del successivo – e aspramente discusso – concordato fra la Santa Sede e la Germania hitleriana, Xie ricorda tuttavia come Pio XI sia stato anche ricordato nella stampa cattolica sinica come il “papa cinese” (p. 109), esplorando così un aspetto poco noto del pur ampiamente dibattuto pontificato di Papa Ratti. Alla base di questa risonanza di Pio XI in Cina sta infatti l’azione diplomatica con cui le gerarchie vaticane giunsero finalmente, nel 1922, a nominare un nuovo nunzio apostolico in Cina, Celso Costantini, alla cui figura va così ricollegata la nascita di effettive relazioni diplomatiche dirette fra la Cina contemporanea e la Santa Sede. Costantini fu il primo delegato apostolico ad insediarsi ufficialmente sul suolo cinese nel 1922, intraprendendo in tal modo una importante azione di riorganizzazione delle istituzioni ecclesiastiche in loco e di parallele negoziazioni con il governo repubblicano del Kuomintang.
Il successore di Costantini, Mario Zanin, si trovò a dover affrontare una situazione ben più difficoltosa durante il pontificato di Pio XII (1939-1958), in anni particolarmente difficili sia per la storia cinese che quella europea. Xie presta particolare attenzione ad una questione particolarmente spinosa, rappresentata dal riconoscimento diplomatico de facto offerto da Papa Pacelli al governo fantoccio del Manchkuo costituito dalle autorità giapponesi nei territori della Manciura occupata (“La questione dello Stato fantoccio di Manciukuo” pp. 149-158): evento che avrebbe segnato in maniera profondamente negativa il successivo evolversi dei rapporti diplomatici fra la Cina e la Chiesa cattolica.
Come facilmente immaginabile infatti la costituzione della Repubblica Popolare nel 1949 segnò una cesura fondamentale nelle relazioni fra la Cina e la gerarchia cattolica. L’avvento della guerra fredda e l’irrigidirsi, su entrambi i versanti, di posizioni sempre più difficilmente conciliabili portarono nel 1951 all’espulsione dell’ultimo delegato apostolico a Pechino, Antonio Riberi, determinando la definitiva rottura dei contatti diretti fra la diplomazia vaticana e il governo comunista. La seconda parte del volume è cosi dedicata a quella che Xie chiama, con una metafora assai interessante, l’“Ostpolitik” della Santa Sede: ovvero un lento e molto cauto tentativo di riavvicinamento da parte della diplomazia vaticana alla Cina, di cui Un lungo cammino esamina le varie fasi e ricorsi sino agli esiti più recenti, raggiunti con il memorandum d’intesa siglato fra la Santa Sede e il governo di Pechino nel 2018: documento di particolare rilevanza in quanto costituisce il primo tentativo di dialogo diretto fra la gerarchia vaticana e la Repubblica Popolare dopo oltre cinquant’anni di silenzio.
Corredato da un ricco apparato di interviste a studiosi sia italiani che cinesi (pp. 273-384), Un lungo cammino approfondisce così questioni di rilevanza fortemente attuale – come il nodo del riconoscimento della Chiesa patriottica cinese o la politica di sinicizzazione che ha guidato l’approccio del governo di Pechino agli affari religiosi in anni recenti – confermando come, a distanza di oltre sette secoli, quella delle relazioni fra la chiesa e la Cina continui a rappresentare una questione eccezionalmente complessa, ricca di criticità e implicazioni storiche, nel pur variegato panorama delle relazioni fra l’Europa e la Cina.
Tommaso Pepe, Guangzhou Maritime University