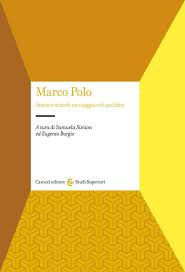Words and Visions around/about Chinese Transnational Mobilities, Firenze University Press, 2023
- May 12, 2024
- 6 min read
Updated: May 15, 2024
Words and Visions around/about Chinese Transnational Mobilities
A cura di Valentina Pedone e Miriam Castorina
Firenze: Firenze University Press, 2023. Pp. 202.

Il libro curato da Valentina Pedone e Miriam Castorina è sia informativo sia accurato sul piano metodologico. Il volume si concentra sul ruolo svolto dalle arti e dalle scienze umane nel rappresentare i movimenti delle persone dalla Cina all’Italia, ma anche a livello globale, tra il ventesimo e il ventunesimo secolo. Il libro, oltre ai saggi delle due curatrici, include articoli di Hao Xu, Andrea Scibetta, Changxu Gao, Chiara Lepri, Giuseppe Rizzuto, Rebecca Ehrenwirth, Martina Renata Prosperi e Giulia Rampolla.
Sulla scia della svolta delle scienze sociali nella direzione della mobilità – una svolta dovuta a studiosi come Tom Cresswell (On the Move: Mobility in the Modern Western World. New York: Routledge, 2006) e John Urry (Mobility. Cambridge: Polity Press, 2007) – i movimenti transnazionali delle persone non sono più visti come accessori alle relazioni economiche, sociali e politiche, ma come aspetti costitutivi di esse. Tuttavia, è solo dopo la pubblicazione d’un importante saggio del sociologo e geografo Peter Merriman e della teorica della letteratura Lynne Pearce (“Mobility and the Humanities”, Mobilities, 12, 4, 2017, 493-508), che gli studiosi hanno cominciato a dedicare attenzione, in maniera sistematica, all’impatto delle migrazioni umane sulla letteratura e sui campi culturali a essa contigui, ad esempio le arti visuali.
Lungo questa linea di ricerca, Words and Visions around/about Chinese Transnational Mobilities, curato da Pedone e Castorina, apre una conversazione rivolta a tutti coloro che studiano la Cina. Il volume esplora infatti l’impatto che le mobilità (al plurale) tra la Cina e l’Italia hanno avuto – e continuano ad avere – sulla produzione culturale, soprattutto sulla letteratura.
Uno dei maggiori punti d’interesse del libro consiste nel fatto che esso non si limita a fornire un punto di vista sociologico sulla produzione letteraria italo-cinese, dal ventesimo secolo fino agli anni della globalizzazione. I capitoli del volume, infatti, presentano delle dettagliate letture ravvicinate (close readings) delle proprie fonti letterarie. La ragione di ciò è che, come scrivono le curatrici nella “Introduzione” (7-10), “l’analisi testuale può illuminare alcuni aspetti specifici dei flussi di mobilità [tra la Cina e l’Italia], che altre metodologie di ricerca difficilmente fanno emergere” (8). Questa osservazione vale in particolare proprio per il saggio di Valentina Pedone (“Rappresentazioni della mobilità lavorativa dalla Cina all’Italia nel caso dello scrittore-operaio Deng Yuehua”, 31-44). Il capitolo steso da Pedone è inserito nella prima parte del libro e presenta gli scritti del migrante Deng Yuehua, originario di Fujian, il quale entrò in Italia nel 1991, e da allora ha lavorato in laboratori artigianali e fabbriche gestiti da altri immigrati cinesi (ad esempio a Prato). Deng Yuehua ha reso conto di questa sua esperienza scrivendo e pubblicando sulla figura del youzi (游子), il girovago, per giornali e riviste locali cinesi, come Cina in Italia, una rivista bilingue di Roma.
Il libro è diviso in tre parti. La prima parte (13-82) analizza la mobilità turistica, economica (come nel caso di Deng Yuehua), studentesca e delle élite sociali, dalla Cina all’Italia. La seconda parte (83-140) reca degli esempi di mobilità inversa, dall’Italia alla Cina. La terza parte (141-194) si concentra infine sulle mobilità dalla Cina verso aree del mondo che non sono l’Italia.
Nella prima parte, il saggio di Miriam Castorina (“Un infinito vagare: visioni della mobilità nell’Italia di Zou Taofen”, 13-29) si concentra principalmente sulla notevole figura del giornalista Zou Taofen (1895-1944) e sulle sue memorie dell’Italia in Pingzong jiyu, 萍踪寄语, (Messaggi da un infinito vagare), risalenti al tempo del suo esilio dalla Cina. Le originali visioni di Zou Taofen raggiunsero un ampio pubblico di lettrici e lettori durante gli anni repubblicani, anche se egli “non ha ancora ricevuto tutta l’attenzione che merita” (Rana Mitter, A Bitter Revolution: China’s Struggle with the Modern World. Oxford: Oxford University Press, 2004, 55).
Sempre nella prima parte del libro, dopo quello di Pedone, l’articolo di Hao Xu (“Paure e speranze: gli studenti universitari cinesi in Italia durante la prima ondata di Covid-19”, 45-60) analizza dapprima i problemi (inclusi i pregiudizi etnici) incontrati dagli studenti universitari cinesi durante la pandemia di Covid-19, e successivamente dirige l’attenzione alla risposta artistica e culturale che la stessa comunità di studenti ha dato alla pandemia.
La prima parte del libro si chiude con l’articolo di Andrea Scibetta, dal titolo “La vita di Mario Tchou nel graphic novel La macchina Zero. Uno scienziato transnazionale sino-italiano” (61-79). Scibetta studia alcuni aspetti strutturali, stilistici, semiotici e di contenuto del grahic novel, di Ciaj Rocchi e Matteo Demonte, La macchina zero (2021). Quest’ultimo narra l’affascinante storia di Mario Tchou (1924-1961), un brillante scienziato italo-cinese, e ricostruisce le fasi del contributo che egli diede sia alla crescita economica dell’impresa di Adriano Olivetti (1901-1960) – l’imprenditore umanista per eccellenza dell’industria italiana – sia alla creazione di uno dei primi computer di nuova generazione, l’ELEA 9003.
La seconda parte del libro tratta della migrazione dall’Italia alla Cina e presenta tre saggi.
Nel primo saggio, “Studio in mobilità. Tian Dewang e la sua esperienza all’Università di Firenze, 1935-1937” (83-97), Changxu Gao ricostruisce il percorso umano e professionale di Tian Dewang, 田德望 (1909-2000), il primo studente cinese a studiare letteratura italiana in Italia sotto la direzione di Attilio Momigliano (1883-1952). Negli anni ’80, Tian Dewang divenne in Cina un noto professore e traduttore di letteratura italiana, il primo a portare a termine una traduzione completa della Divina Commedia in cinese.
Il saggio di Changxu Gao è seguito da quello di Chiara Lepri intitolato “Marco Polo ritorna in Cina. La serie televisiva di Giuliano Montaldo (1982)” (99-116). L’articolo di Lepri include una intervista originale, del 2022, al regista Montaldo, e segue passo dopo passo il processo di collaborazione (che comprendeva partners dagli Stati Uniti, dal Giappone, dalla Germania e dalla Francia), che portò alla realizzazione della serie TV sui viaggi del mercante veneziano Marco Polo. La serie fu la prima co-produzione tra l’Italia e la Cina e divenne funzionale al consolidamento dell’amicizia sino-italiana dopo che nel 1970 vennero stabilite le relazioni diplomatiche con la Cina comunista.
La seconda parte del libro è chiusa dal saggio di Giuseppe Rizzuto, dal titolo “Studenti cinesi di ritorno e produzione culturale. Il caso degli ex-studenti di opera in Italia” (117-137). Rizzuto inquadra il proprio contributo entro le coordinate teoriche fornite da Pierre Bourdieu (Il campo della produzione culturale, 1993) e da Arjun Appadurai Modernità in polvere, 1996). Egli analizza l’esperienza degli studenti cinesi che in Italia frequentano corsi di opera per diventare cantanti, e poi ritornano nel loro Paese. Rizzuto sostiene che la mobilità e la produzione culturale possono essere analizzate sia secondo la loro dimensione strutturale, sia secondo quella immaginaria. La dimensione strutturale è composta da accordi internazionali tra enti e governi, leggi concernenti la mobilità globale, cambiamenti economici e sociali, investimenti privati nell’istruzione. Dall’altro lato, la dimensione immaginaria è delineata dagli stili di vita adottati dalle famiglie della media borghesia, quella che si può permettere un certo tipo di mobilità transnazionale, legata a motivi di studio. Gli studenti di ritorno in Cina, secondo Rizzuto, sono sia i soggetti che promuovono un simile processo di mobilità, sia coloro che ne costituiscono l’oggetto, e da questa stessa dinamica vengono plasmati.
A parte le letture ravvicinate dei testi (letterari), un altro punto di forza del volume è rappresentato dal modo in cui esso invita chi legge, come Pedone e Castorina scrivono nella “Introduzione”, a sfuggire alle “etichettature culturali”, da un lato, e a superare “le barriere culturaliste”, dall’altro (9). L’etichettatura culturale, infatti, è per così dire il lato negativo d’un approccio accademico basato sui Cultural Studies, un approccio che certamente punta a stimolare la discussione interculturale, ma che spesso, almeno oggi, finisce per creare degli ambiti di studio separati e chiusi in sé stessi, nei quali i ricercatori sono ai ferri corti gli uni con gli altri.
I tre saggi della terza e ultima parte del libro contrastano il rischio della auto-referenzialità nei dibattiti accademici e sono dedicati a dei casi specifici di mobilità culturale globale (non italiana) dalla Cina verso – rispettivamente – la Tailandia, gli USA e il Canada. I tre saggi inclusi in questa sezione sono quelli di Rebecca Ehrenwirth (“Viaggio in una terra straniera. Immaginare la migrazione nella letteratura sinofona della Tailandia”, 141-157), Martina Renata Prosperi (“Scrivere per i mondi e per le parole. La riflessione sulla lingua nella produzione letteraria di Yiun Li”, 159-174), e Giulia Rampolla (“Incontri urbani transnazionali. Erranze esistenziali nella raccolta Shenzheners di Xue Yiwei”, 175-194). Ehrenwirth, Prosepri e Rampolla riescono a mettere in movimento gli steccati culturalisti, e a problematizzare le etichettature culturali, a cui fanno riferimento le curatrici del volume nella loro “Introduzione”. Infatti, le tre studiose mostrano come la migrazione solo immaginata, la esofonia (lo scrivere in una lingua che non è la propria lingua madre) e una traiettoria di vita cosmopolita e nomadica creano contatto e scambio tra le persone, ovvero un alto tasso di “ibridazione letteraria e rimescolamento culturale”, come scrive Rampolla (175).
Words and Visions around/about Chinese Transnational Mobilities, curato da Valentina Pedone and Miriam Castorina, stimola i pensieri di studiosi e studenti che si dedicano all’Italia, alla Cina e alla mobilità geografica. L’immagine della Cina che emerge da questo libro è molto diversa da quella che emergeva dai primi, pioneristici lavori sulla Cina di intellettuali italiani, come nel caso dei documentari La muraglia cinese (1958) di Carlo Lizzani, e Kung-Chuo – Cina (1972) di Michelnagelo Antonioni. La Cina di oggi è partner e collaboratrice – co-editrice, co-curatrice, co-produttrice, co-autrice, co-traduttrice – non è più un esotico ‘oggetto’ di contemplazione orientalistica.
Andrea Sartori
Nankai University