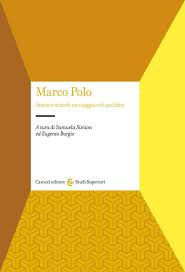Orienting Italy: China through the Lens of Italian Filmmakers, SUNY Press, 2022
- Jan 18, 2024
- 7 min read
Updated: May 15, 2024

Mary Ann McDonald Carolan, Orienting Italy: China through the Lens of Italian Filmmakers, New York: SUNY Press, 2022. Pp. xv + 184.
Il libro di Mary Ann McDonald Carolan amplia le coordinate degli odierni dibattiti riguardanti i rapporti tra l’Est e l’Ovest. Orienting Italy si concentra infatti sulle rappresentazioni cinematografiche della Cina e della sua popolazione – inclusa quella residente all’estero – in un selezione di opere di registi italiani.
Il libro è articolato in sei capitoli principali, oltre all’Introduzione, alla Conclusione e a un agile indice di nomi e concetti. Il primo capitolo è dedicato a Carlo Lizzani (“Documenttare la Cina tra fatti e finzioni: La muraglia cinese, 1958”, pp. 15-38), mentre il secondo e il terzo capitolo trattano rispettivamente dei lavori di Michelangelo Antonioni e Bernardo Bertolucci (“Un regista italiano in Cina: Chung Kuo-Cina, 1972”, pp. 39-62 e “Racconto della Città Proibita: L’ultimo imperatore, 1987”, pp. 63-84).
Nella seconda parte del libro, Carolan affronta il cinema italiano sulla Cina a noi cronologicamente più prossimo. Il quato capitolo è su Gianni Amelio (“Orientando il neorealismo: La stella che non c’è, 2006”, pp. 85-102). Il quinto capitolo offre una lettura comparativa di due film di due registi differenti: Stefano Incerti e Andrea Segre (“La donna cinese in Italia: Gorbaciof, 2010 e Io sono Li, 2011”, pp. 103-126). Il sesto e ultimo capitolo si concentra infine su un lavoro di Riccardo Cremona e Vincenzo De Cecco (“Documentando la gioventù immigrata cinese e il pregiudizio anti-immigrati degli Italiani: Miss Little China, 2010”, pp. 127-142).
In realtà, Orienting Italy termina menzionando, tra altri film molto recenti, un corto del 2020 di Giacomo Sebastiani, dal titolo Zheng (p. 149). Questo film è interamente parlato in mandarino, riporta sottotitoli italiani, ed è la punta più avanzata, per così dire, della traiettoria evolutiva del cinema italiano sulla Cina tracciata da Carolan. Tale traiettoria, infatti, giunge al corto in mandarino di Sebastiani muovendo dalla “muraglia”, o barriera – reale, metaforica e linguistica – del documentario di Lizzani. Quello di Sebastiani è un film che, per la prima volta, espone integralmente il pubblico italiano alla lingua cinese, evitando pertanto di scivolare nell’iniziale esoticismo della rappresentazione di Lizzani, ma anche di ricorrere massicciamente, come faceva Antonioni, al silenzio, per ragioni sia strategiche (sul set non era possibile comprendersi), sia estetico-artistiche.
Nella sua analisi dei film, Carolan meritoriamente non eccede nell’impiego di categorie interpretative generali come Sud Globale, orientalismo (Edward Said. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978), o la dicotomia colonial/post-colonial, ormai per certi versi logora e inadatta a comprendere un mondo in cui le relazioni internazionali – economiche e politiche – sono molto diverse rispetto a cinquanta, quaranta, o anche trenta anni fa.
Non a caso, il termine orienting (“orientare”), nel titolo dell’ultimo libro di Carolan, non è un sostantivo che ha la facoltà di immobilizzare – se non addirittura di pietrificare – i termini di una relazione – Italia e Cina – in immagini, impressioni, e percezioni astratte, anti-storiche, sempre identiche a sè, sottratte alla possibilità del cambiamento. In fondo, quest’ultimo è proprio il caso d’espressioni fino a oggi molto utilizzate dalla critica culturale, quali, ad esempio, “altro orientalizzato”. La novità del libro di Carolan risiede proprio nel suggerire argomenti che sblocchino le coordinate d’un discorso critico forse avvitato su sè stesso, e paradossalmente indietro rispetto allo svolgersi dei rapidi eventi della storia.
È opportuno ricordare che in questi anni un altro italianista interessato all’Asia, Michele Monserrati, ha provato a rinnovare dall’interno il concetto di orientalismo proposto da Said nel 1978, coniando la formula “orientalismo relazionale” (Searching for Japan: 20th Century Italy’s Fascination with Japanese Culture. Liverpool: Liverpool UP, 2020). D’altra parte, nella prospettiva degli studi sulla cooperazione internazionale, gli studiosi di scienza e filosofia politica Valeria Lauria e Corrado Fumagalli hanno sostenuto, a ragion veduta, che al 2015 non esisteva affatto un modello uniforme di Sud Globale (a carico dei BRICS), per qual che riguarda il sostegno allo sviluppo (Valeria Lauria e Corrado Fumagalli, “BRICS, The Southern Model, And the Evolving Landscape of Development Assistance: Toward a New Taxonomy”, Public Administration and Development, 39, 4-5, 2019, pp. 215-230). Tale modello uniforme, nell’analisi di Lauria e Fumagalli, non esiste in rapporto alle 1) motivazioni al sostegno (ad es.: la mera prossimità geografica, o l’estensione della sfera d’infulenza a territori un tempo inclusi nei confini nazionali); 2) agli strumenti del sostegno (ad es: la riduzione del debito, o la cooperazione tecnico-professionale); 3) alla modalità d’erogazione del sostegno (ad es.: la donazione incondizionata, o l’aiuto vincolato a determinati parametri economico-finanziari).
Orienting, “orientare”, in Orienting Italy di Carolan, non è un sostantivo ma un verbo che indica appunto la possibilità d’un evolving landscape, cioè dello sviluppo d’una relazione, come sostiene anche Monserrati: un tentativo di comprensione dell’altro che s’articoli nella negoziazione e nella mediazioni di reciproci interessi, includendo in essi i confini che delimitano le identità e i linguaggi di ciascuno. Carolan sembra anche suggerire che, nell’esecuzione di questo difficile compito di negoziazione e mediazione, gli individui – Cinesi o Italiani – non dovrebbero essere eccessivamente timorosi di commettere inaccuratezze o errori: gli errori sono parte d’un percorso d’orientamento nella misura in cui aprono alla conoscenza riflessiva e all’auto-correzione (bando alle anime belle che puntano il dito, insomma).
Ad esempio, è vero che nel film di Incerti, Gorbaciof (2010), Lila – la protagonista femminile cinese, interpretata da Mi Yang, una delle attrici di maggior successo della sua generazione in Cina - “è una pedina [...] in un sistema di relazioni essenzialmente patriarcale” (p. 110). Tuttavia, uno dei personaggi maschili che contribuisce alla costruzione di quel sistema patriarcale è Gorbaciof (interpetato dall’italiano Toni Servillo), ovvero qualcuno con cui Lila non ha in comune la lingua, ma solo “un senso di marginalità condivisa” (p. 109). È nel nome di questa comune marginalità che Gorbaciof dà a Lila il denaro necessario a ripagare i debiti di gioco del padre, difende la donna contro i giovani delinquenti napoletani che la insultano, e infine le promette “di farla scomparire da Napoli ragalandole un volo per una destinazione lontana” (p. 108).
In Io sono Li (2011) di Segre, Shun Li, interpretata da Zhao Tao, deve ripagare un debito come Lila nel film di Incerti. Per questo, Shun Li lavora in una fabbrica a Roma, in un bar nella laguna di Chioggia, e infine in un altro posto tutt’altro che ideale sulla terraferma. In entrambi i film, il “debito” è un dispositivo narrativo che consente alla storia di svilupparsi e che, al tempo stesso, è figura della reciprocità: ripagare un debito significa esporsi al rischio d’estorsioni, ma anche cercare aiuto e forse trovarlo – il “debito” è così cifra d’un mutuo impegno per un fine.
Uno degli aspetti più interessanti di Orienting Italy è l’attenzione che l’autrice rivolge a un mutamento estetico e stilistico, nelle rappresentazioni della Cina, che può essere interpretato come un significativo cambiamento nell’atteggiamento degli Italiani verso i Cinesi. L’ultimo imperatore (1987) di Bertolucci, ad esempio, era cartterizzato dalla marcata spettacolarizzazione della sua materia narrativa, la quale si traduceva in un “sovraccarico percettivo” (p. 83) sui sensi dello spettatore occidentale. La grande muraglia (1958) di Lizzani e Chung Kuo-Cina (1972) di Antonioni, invece, erano accompagnati da una voce fuori campo che sottolineava l’estranetà del narratore alle vite dei Cinesi che quei due particolari documentari si prefiggevano di raccontare. In tutti e tre questi casi, la logica dello spettacolo, da un lato, e il distacco etnografico del regista, dall’altro, erano gli indizi simmetrici – opposti e speculari – d’una medesima impossibilità, quella della interazione con l’altro.
Film più recenti – a partire dal ri-orientamento e dalla rivalutazione del neorealismo da parte di Amelio in La stella che non c’è (2006) – adottano una strategia narratologica differente. In questo senso, Carolan scrive che nei lavori di Incerti e Segre, ma anche in Miss Little China (2010) di Cremona e De Cecco – almeno fino a un certo punto – è all’opera un diverso sguardo cinematografico, maggiormente poetico, uno sguardo informato da quello che Pier Paolo Pasolini chiamava “cinema di poesia” (Il cinema di poesia, 1965).
Questo tipo di cinema, sostiene Carolan, fa un uso esteso dell’equivalente cinematografico del “discorso indiretto libero” in letteratura (p. 112), e intenzionalmente confonde il punto di vista del narratore (che può essere oppure no quello del regista) con il punto di vista del protagonista. In tal modo, i recenti film Italiani sulla Cina ci consegnano un’immagine più empatica del Paese e della sua popolazione, creando uno spazio, come nel caso di Miss Little China, per un messaggio di “speranza univresale rivolto alle generazioni future” (p. 137).
Non è troppo fuorviante dire, inoltre, che quel che Carolan ha fatto con il suo libro sull’Italia e la Cina echeggia gli sforzi compiuti dal filosofo politico Michael Sandel sull’altro lato dell’Atlantico. Sandel, infatti, sta cercando di stabilire un ponte tra la cultura americana e quella cinese denunciando, da un lato, i disagi delle democrazie liberali e, dall’altro lato, mettendo a fuoco i principi dell’etica taoista che potrebbero essere meglio adattati a un ambiente democratico riformato. Si vedano, ad esempio, i casi della “spontaneità”, o dell’ “essere un certo sè” (ziran 自然), ma anche il principio dell’ “azione non-assertiva” o della “non-interferenza”(wu wei 無為), come valide alternative alla “meccanizzazione del cuore e della mente” (ji xin 機心). Quest’ultima è per Sandel ormai tipica d’una società occidentale incentrata sui parametri del darwinismo sociale, ovvero su ciò che già nel 1882 uno psichiatra positivista italiano, Enrico Morselli, definiva “concorrenza per la vita” (il che è molto simile a quel che oggi Sandel intende per market society, quale passo ulteriore e ‘degenerativo’, per così dire, rispetto alla market economy).
Alla base delle preoccupazioni di Sandel e di Carolan v’è la conspevolezza che, in un mondo globalizzato in rapida trasformazione, ciascuno di noi deve considerare “la responsabilità morale che è tenuto ad avere verso gli altri in quanto cittadini e cittadine” (Evan Osnos, “China’s Encounter with Michael Sandel”, in Encountering China, a cura di Michael J. Sandel e Paul J. D’Ambrosio. Cambridge: Harvard UP, 2018, xi).
Orienting Italy. China through the Lens of Italian Filmmakers è un libro di cui oggi v’è bisogno, poichè non fa iporiticamente passare sotto silenzio le ansie da competizione che l’immigrazione cinese ha innescato in Italia. Tale è il caso ad esempio, de La stella che non c’è (2006) di Amelio, un film che fa un libero riferimento al romanzo del 2002 di Ermanno Rea, La dismissione, il quale si soffermava sull’impatto in Italia dei lavoratori e del capitale cinesi.
Tuttavia, i toni de La dismissione erano attuali venti o quindici anni fa, e lo sono meno nell’attuale scenario d’una modernizzazione globale – con caratteristiche occidentali o cinesi. In questo scenario, o evolving landscape, il libro di Carolan è un utile strumento culturale che studenti e studiosi di italiano e cinese, di cinema e media, possono leggere per addestrarsi a trasformare quella che a volte rischia di essere una competizione senza scrupoli, in un progetto cooperativo segnato dal reciproco rispetto e dalla curiosità nei confronti delle rispettive alterità (“[...] perché siano visibili / contraddizioni e identità fra noi. / Se un senso esiste, è questo”, Franco Fortini).
Andrea Sartori
Nankai University