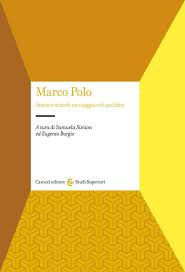La via della seta a tavola, Edilingua, 2023
- Feb 12, 2024
- 4 min read
Updated: May 15, 2024
La via della seta a tavola Guida all’uso dei testi e delle parole della cucina per l’insegnamento dell’italiano a sinofoni
a cura di Pierangela Diadori, Giuseppe Caruso e Zhao Shiwei, Roma: Edilingua, 2023, pp. 128.

La via della seta a tavola, parte della collana Nuova DITALS Formatori edita da Edilingua, è frutto dell’attività di ricerca e sperimentazione del Centro di Ricerca e Servizi DITALS dell’Università per Stranieri di Siena, diretto dalla prof.ssa Pierangela Diadori. Il volume, curato da Pierangela Diadori, Giuseppe Caruso e Shiwei Zhao, si propone come una guida ai testi e alle parole della cucina rivolta agli insegnanti di italiano a sinofoni, ma, considerato l’approccio comparativo adottato, può essere impiegato anche da chi insegna cinese a italofoni, oltre che dagli studenti cinesi e italiani che vogliono approfondire l’argomento.
La via della seta a tavola si divide in due parti principali, la prima composta da otto brevi articoli che spaziano dagli studi sui panorami linguistici all’intercultura, passando per traduzione e letteratura. L’ampio spettro di argomenti presentati, risultato della collaborazione tra italianisti e sinologi cinesi e italiani, rende il volume perfetto anche per essere presentato a lettori non madrelingua alla ricerca di materiale per la tesi di laurea o per una tesina di fine corso. La seconda parte, concentrata invece sulla didattica della lingua italiana per apprendenti sinofoni in contesti LS/L2, si compone di un articolo che approfondisce la cucina italiana tra le pagine di due dei manuali di lingua più usati in Cina e tre unità di lavoro di livello A2, B1 e B2 già pronte per essere usate in classe.
Date tali premesse, sorge spontanea una domanda: perché parlare di cucina lungo la Via della seta nella classe di lingue, in modo particolare durante la lezione di italiano in Cina? La risposta è molto semplice: perché la gastronomia è uno degli aspetti che più accomunano cinesi ed italiani. Con questo non si intende parlare solamente dei prodotti “Made in Italy” che spopolano nei supermercati cinesi di cui parla Lijie Chen ("Le marche dei cibi e dei vini italiani di moda in Cina", pp. 43-49) nel suo articolo o dei celebri ristoranti cinesi in Italia, di cui scrivono Beatrice Fanetti e Fabio Parasecoli (“I ristoranti cinesi in Italia”, pp. 19-27) , ma della passione comune per la buona cucina, patrimonio culturale immateriale condiviso da italiani e cinesi, un vero e proprio elemento d’identità culturale. La magia della cucina unisce i due Paesi anche per un altro importantissimo motivo: il potere della condivisione dei pasti – basti pensare che la versione cinese del proverbio “Chi mangia solo, muore solo” è identica al corrispettivo italiano. Così come cucinare è un gesto d’amore, l’idea di riunirsi a tavola per condividere i piatti preparati è certamente quella che più rappresenta la definizione delle parole “famiglia” e “casa” nel vocabolario mentale dei parlanti di entrambe le lingue. Che si tratti del cenone di Capodanno nelle case italiane o della Festa di primavera in quelle cinesi, il cibo è un elemento culturale che ci unisce, ci accomuna e ci rende uguali nelle nostre differenze. È proprio in questo approccio comparativo che risiede il punto di forza de La via della seta a tavola, in quanto studiare l’italiano non significa solamente saper coniugare il verbo “cucinare”, ma anche usare la lingua target per parlare di gastronomia e tradizioni, sia quella del proprio paese d’origine che quella di una cultura a cui ci si sta avvicinando a piccoli passi.
Oltre che importantissima a livello culturale, la cucina ci fornisce anche spunti infiniti per le attività in classe: si possono studiare i cinque sapori per poter dire al barista di fiducia che il suo caffè è troppo amaro, ma si può anche decidere di insegnare come ordinare la pizza d’asporto con una semplice telefonata o come fare la spesa online, imparando così i nomi di verdure, carne e pesce per creare piatti gustosi. Come ben sappiamo, la cucina cinese e italiana sono entrambe molto apprezzate a livello internazionale, tanto da ricoprire il primo e il quinto posto nella lista delle “100 migliori cucine al mondo” stilata da TasteAtlas (https://www.tasteatlas.com/tasteatlas-awards-23-24), che include anche dieci piatti italiani (al quarto posto la regina della gastronomia napoletana, la pizza) e sei cinesi (i guotie, i deliziosi ravioli alla piastra, sono al quinto posto) tra i “100 migliori piatti al mondo”. Se questa “battaglia di bontà” non dovesse bastare a riscaldare gli animi degli studenti per decidere a colpi di superlativo relativo quale sia il piatto più buono del mondo, si può sempre tentare un approccio che avvicini di più le due culture, lasciando più spazio alle somiglianze che alle differenze, visto che le due cucine variano da regione in regione (se non di città in città), con una moltitudine di piatti tradizionali e specialità locali tutti da scoprire. Così come chiedere a un emiliano di descrivere il sapore delle panelle siciliane potrebbe dimostrarsi un’ardua sfida, in Cina nord e sud litigano bonariamente per decidere se gli zongzi, tipici involtini di riso glutinoso serviti per la Festa delle barche del drago, siano da gustare dolci o salati.
Parlare di cibo in chiave comparativa, così come ci insegna.
La via della seta a tavola, rende la lezione di italiano più stimolante e interattiva perché, oltre a essere una fonte di infinite discussioni e progetti che ci permette di mettere da parte i libri di grammatica e “sporcarci le mani in cucina” (in senso sia metaforico che letterale), aiuta anche a creare individui “interculturalmente competenti”, capaci di tollerare, rispettare e ascoltare gli altri, superando pregiudizi e stereotipi, come stabilisce il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. È il maestro Umberto Eco a ricordaci che «capirsi fra culture diverse non significa valutare ciò cui ciascuno deve rinunciare per arrivare a essere uguali, bensì capire bene reciprocamente ciò che ci separa e accettare questa diversità» (Umberto Eco, Migrazioni e intolleranza, Milanio: La nave di Teseo, 2019, p, 34).
Letizia Vallini
Nankai University